Mauro Ferrari su "Una spiga" di Sheila Moscatelli
- almanacco
- 12 set 2025
- Tempo di lettura: 4 min
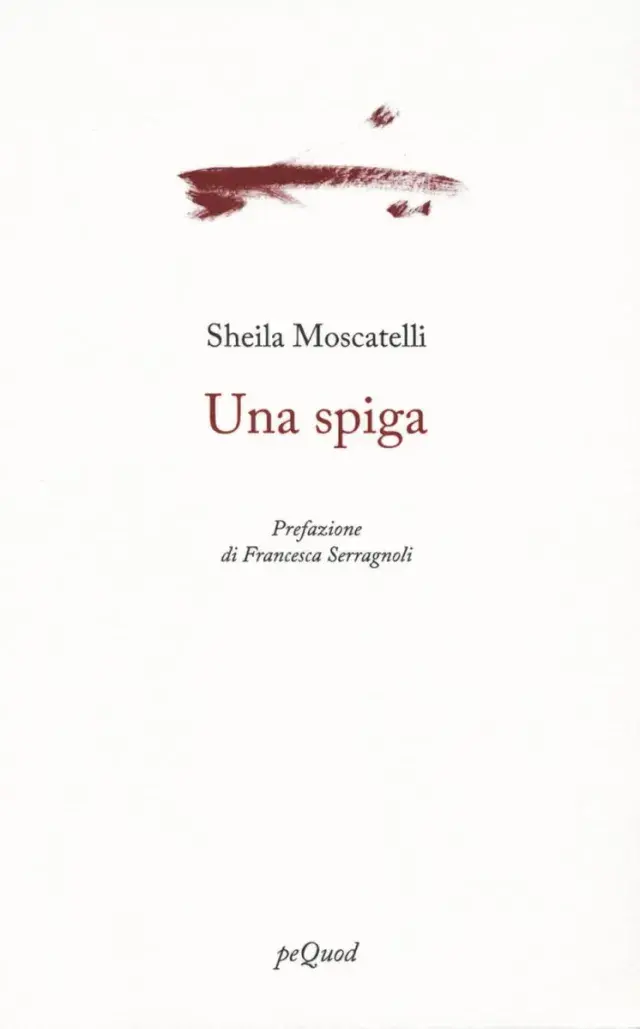
Sheila Moscatelli, Una spiga, peQuod, Ancona 2025
Ci sono raccolte poetiche fortemente strutturate attorno a un nucleo ideativo o narrativo; altre affidano la propria coesione alla coerenza espressiva o del punto di vista adottato sul mondo. Una spiga di Sheila Moscatelli appartiene propri a questa seconda categoria. Giustamente Francesca Serragnoli, in prefazione, evidenzia al riguardo una caratteristica che definisce “accoglienza”, cioè la capacità di “vedere” le piccole cose, trasfigurare insomma la realtà in una visione, vedendo “l’eterno dentro il quotidiano” senza per questo, almeno mi pare, dare al termine una qualche coloritura religiosa (il che richiederebbe, in altra sede, una riflessione su cosa possa essere una spiritualità laica, la quale esalti la sacralità del reale e il nostro rapporto con esso).
Che Sheila Moscatelli riesca in questo intento senza (giusto ancora il rilievo della prefatrice) enfatizzare la presenza dell’Io è un traguardo importante: la poetessa non ci racconta, non fa diarismo né minimalismo autobiografico: semplicemente (si fa per dire) instaura con il mondo un dialogo basato sullo sguardo; i quadri poetici hanno una qualità fotografica, persino, a tratti, iper-realistica, travalicando i limiti e le contingenze della metrica, per affidarsi a un verso libero affilato, fortemente denotativo. Riporto l’intera poesia a p. 17:
Le ombre delle quattro, allungate
sul canneto al margine del campo.
Il sole si appoggia all’orizzonte
Sotto la luna, piena in anticipo
Pallida sopra nuvole rosse
E rami spogli, tesi verso il cielo. (p. 17)
L’io è veramente un punto di vista, senza per questo abdicare a una riflessione condotta in re, per così dire, che parta proprio dal rapporto con il mondo, un mondo di oggetti ed esseri che sono più che presenze e appaiono con la nitidezza della visione, stagliati sullo sfondo di una natura oggettivizzata, che proprio per questo ci appare sulla pagina un “misterioso segreto sussurrato” (p. 26, in corsivo nel testo).
Né si tratta di una poesia che trasforma il mondo in uno spettacolo, in un paesaggio da osservare: anzi, lo sguardo sereno della poetessa indaga su cosa risieda al di sotto della realtà visibile, per “vedere il mondo in un granello di sabbia” come direbbe l’amato Blake. Questo sguardo, infine, giunge a evidenziare faglie, rotture, disequilibri: la realtà non è un giardino pacificato, ma obbedisce in fondo a logiche non umane, oggettive e persino materialistiche senza temere di contraddire quanto si diceva sulla spiritualità (appunto: laica).
Si instaura nella sezione Il grano ha resistito una sorta di fremito inquieto, che percorre tutti i testi ed appare più evidente in affioramenti come “In soffitta famiglie di pipistrelli / nessun muro a proteggere il sonno dei bambini / la casa spazzata dal vento delle bombe” (p. 37). Quale condotta adottare quindi di fronte alle minacce? “Il corpo punta a contenere i danni. / Poi il dolore, che frena e protegge / insegna movimenti nuovi, mentre la pelle / mostra l’efficienza della rigenerazione” (p. 39): cautela, ma fiducia nella resilienza del corpo e della materia, dunque. Il mondo mostra una “bellezza feroce” (p. 40): ancora Blake, il confronto con il volto della tigre. “Il grano ha resistito (p. 41) proprio perché ha saputo affrontare il reale con queste armi.
La sezione Vicino alle radici, la più schiettamente lirica della raccolta, ci pare costruita attorno all’idea della costruzione e della condivisione (“Ho fatto il pane pensando a noi”, p. 51), in cui affiora anche l’idea di una comunità umana, incentrata sull’amore di coppia, che si opponga a una “natura ognor verde, [che] anzi procede per sì lungo cammino / che sembra star.” (La ginestra). È questa, per Moscatelli, l’idea di “radici”.
Le parole di domani è il titolo della terza sezione: “Nessuno resta integro se vive” è la straordinaria chiusa del testo a p. 64, che espande il nucleo tematico della raccolta; guardando indietro, alla blakeana “innocenza”della gioventù, il presente (la corruzione ma anche la conoscenza, in una parola l’”esperienza”) e il futuro sono rappresentati da “semi e pazienza” (p. 67) per proiettarsi nel futuro; con il primo lemma che rimanda non solo al ciclo vitale che già richiama resistenza, ma anche all’esigenza di (ri)nascita, esplicitamente è collegato alla maternità. “Accolgo la vita che accade” (p. 70) non indica quindi né passività né un semplice atteggiamento di apertura e accettazione del mondo, bensì apre a una dimensione di felicità conseguita tramite questo percorso di cpmprensione, che “non è cosa semplice”, e che richiede un rapporto corporale, diretto e fisicamente intenso con le cose del mondo e il loro ciclo.
Cito interamente, al proposito, la splendida poesia a p. 74:
Vorrei farmi piccola, abitare il vaso come bosco
Cibarmi del raccolto di due fagioli e cinque lenticchie
Germogliati nel cotone di una classe elementare.
Crescere – muschio sul cerchio di pietre, verde
Radice di smeralo incastonata al dito
Incontrare la farfalla del borgo tra lampi d’ambra
Cadere – a terra – come sabbia nella pioggia.
Siamo “Creature – di fronte a cui la morte si spezza” (p. 76), espliciterà la poetessa. E non siamo lontani dallo straordinario finale della decima Elegia Duinese di Rilke: “E noi, che pensiamo alla felicità / come a qualcosa che sale, sentiremmo / l’emozione, che quasi ci sgomenta, / di quando una cosa felice cade.”



























Commenti